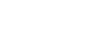La muratura a sacco rappresenta una delle tecniche costruttive più diffuse nel patrimonio architettonico italiano, utilizzata per secoli nella realizzazione di edifici storici, chiese, palazzi e fortificazioni.
Questo sistema costruttivo si caratterizza per una struttura a tre strati: due paramenti esterni ordinati in pietra o mattoni e un’intercapedine centrale riempita con materiale sciolto come pietrame irregolare, ghiaia, terra e frammenti di laterizio. Le origini di questa metodologia risalgono all’antico Egitto e alla Grecia classica, dove veniva chiamata emplekton, per poi essere perfezionata dai Romani con l’opus caementicium.
Nonostante sia stata progressivamente abbandonata nel Novecento a favore di tecnologie più moderne, la muratura a sacco rimane protagonista in migliaia di edifici ancora abitati.
I vantaggi economici e termici che hanno reso celebre questa tecnica costruttiva
La muratura a sacco ha dominato l’edilizia per secoli grazie alla sua straordinaria convenienza economica e alla rapidità di esecuzione, caratteristiche che la resero accessibile anche per progetti di grandi dimensioni. Il principale vantaggio risiede nell’utilizzo intelligente dei materiali: mentre i paramenti esterni richiedevano pietre squadrate o mattoni lavorati da maestranze specializzate, il riempimento interno sfruttava scarti di cantiere, materiali di recupero e risorse facilmente reperibili sul territorio.

Questo permetteva di abbattere drasticamente i costi rispetto alle murature omogenee completamente in pietra squadrata, rendendo possibile la costruzione di edifici imponenti anche con budget limitati. Lo spessore murario generoso, spesso superiore al metro, offriva inoltre un eccellente isolamento termico naturale, garantendo ambienti freschi d’estate e protezione dal freddo invernale grazie all’elevata massa termica.
La capacità di accumulare calore durante il giorno e rilasciarlo gradualmente stabilizzava le temperature interne creando comfort abitativo. Dal punto di vista estetico, questa tecnica consentiva di realizzare facciate di pregio con finiture elaborate, mantenendo costi contenuti per la struttura complessiva.
Le criticità strutturali e i rischi sismici della muratura a sacco moderna
Il limite principale della muratura a sacco riguarda la mancata collaborazione strutturale tra i paramenti esterni e il nucleo interno, problematica che emerge drammaticamente durante eventi sismici. Sotto sollecitazioni orizzontali, le due facce della muratura tendono a comportarsi in modo indipendente, separandosi e provocando il collasso fuori dal piano della parete, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per la stabilità dell’edificio.
Il degrado progressivo del riempimento interno aggrava ulteriormente la situazione: infiltrazioni d’acqua, assestamenti differenziali, decomposizione dei leganti e cicli di gelo-disgelo riducono la coesione del nucleo creando vuoti e discontinuità che compromettono portanza e stabilità. I diatoni, elementi lapidei che dovrebbero collegare i paramenti attraversando l’intero spessore, sono spesso insufficienti o degradati, rendendo la muratura vulnerabile.
La difficoltà diagnostica costituisce un’ulteriore criticità: ispezionare l’interno della muratura richiede indagini invasive costose o strumentazioni sofisticate come georadar e termografie. Molti edifici presentano condizioni interne peggiori rispetto all’apparenza esterna, generando sorprese durante le ristrutturazioni. Gli interventi di consolidamento, come iniezioni di miscele leganti, tirantature metalliche o intonaci armati, risultano complessi e onerosi, richiedendo competenze specialistiche per garantire efficacia senza alterare il valore storico-architettonico.